Il panorama televisivo americano dell’autunno 2005 era dominato da polizieschi e medical drama. L’emittente via cavo Showtime tentò di fare qualcosa di completamente diverso. Lanciò infatti un esperimento tanto ambizioso quanto peculiare: Masters of Horror.
Masters of Horror era una serie antologica che riuniva alcuni dei più celebri registi del genere in un formato inedito per l’epoca. Ogni episodio, della durata di un’ora, rappresentava un cortometraggio horror completamente autonomo, firmato da un “maestro” riconosciuto del genere.
Un’operazione che, a quasi vent’anni di distanza, merita di essere riesaminata. Non solo per il suo valore storico, ma anche per comprendere quanto fosse ancorata al passato del genere piuttosto che proiettata verso il suo futuro.
Il creatore della serie era Mick Garris, regista e sceneggiatore con una lunga carriera nell’horror televisivo, noto soprattutto per gli adattamenti di Stephen King come The Stand e The Shining. Masters of Horror nacque da un’idea tanto semplice quanto affascinante: dare carta bianca ai maestri dell’horror cinematografico. Liberandoli così dai vincoli commerciali dei lungometraggi e dalle restrizioni censorie della televisione generalista.
Il risultato furono due stagioni per un totale di 26 episodi, trasmessi tra il 2005 e il 2007. Ancora oggi rappresentano un documento straordinario delle potenzialità e dei limiti dell’horror d’autore in formato televisivo.
Genesi e Struttura: Un Progetto Nato dalla Passione
La genesi di Masters of Horror ha qualcosa di romantico e quasi mitologico nel mondo del cinema di genere.
Tutto iniziò con una serie di cene informali organizzate da Mick Garris a Los Angeles. A queste parteciparono registi come John Carpenter, Tobe Hooper, John Landis, Joe Dante e altri maestri dell’horror. Tali incontri, iniziati nel 2002, erano occasioni di scambio e confronto tra artisti che, nonostante la fama, faticavano sempre più a trovare spazio nel sistema hollywoodiano degli anni 2000. Una Hollywood sempre meno incline a rischiare su progetti horror d’autore.
Da queste cene nacque l’idea di creare uno spazio creativo dove questi registi potessero esprimersi liberamente, con budget contenuti, ma con totale libertà artistica. Showtime, rete via cavo nota per la sua apertura a contenuti adulti e controversi, si dimostrò il partner ideale per l’operazione. Offrì infatti un formato di un’ora per episodio e garantì l’assenza di censure significative.
La struttura antologica, scelta per la serie, rappresentava un ritorno alle radici dell’horror televisivo. Impossibile non richiamarsi ai grandi classici come The Twilight Zone, Night Gallery o Tales from the Crypt. Ogni episodio era completamente autonomo, senza personaggi o trame ricorrenti. Si permetteva così ai registi di concentrarsi su una singola idea horror senza doverla diluire o complicare con sottotrame o archi narrativi estesi.
Questa formula, apparentemente semplice, nascondeva però una sfida considerevole. Condensare in appena sessanta minuti una storia horror efficace, con personaggi credibili e una progressione narrativa soddisfacente. Una sfida che, come vedremo, alcuni registi hanno saputo cogliere meglio di altri.
Masters of Horror: Chi sono I Maestri Dietro la Macchina da Presa
Il principale punto di forza di Masters of Horror era indubbiamente il suo cast di registi. Un vero e proprio pantheon dell’horror cinematografico che raramente si era visto riunito in un unico progetto televisivo. Analizzando i nomi coinvolti, emergono tre figure di particolare rilievo, sia per il loro status nel genere che per il loro contributo alla serie.
Il già citato John Carpenter, autore di capolavori come Halloween, La cosa e Fog, partecipò a entrambe le stagioni con due episodi: “Cigarette Burns” e “Pro-Life“. Il primo, in particolare, è considerato unanimemente uno dei punti più alti della serie. Una riflessione meta-cinematografica sul potere delle immagini e sull’ossessione cinefila che richiama il suo classico “Il signore del male” aggiornandone le tematiche all’era digitale.

Dario Argento, maestro italiano del giallo e dell’horror visionario, portò il suo inconfondibile stile in due episodi: “Jenifer” e “Pelts“. Entrambi caratterizzati da un forte componente erotico-perturbante e da una violenza grafica tipicamente argentiana. Questi episodi rappresentavano un tentativo di tradurre in formato televisivo americano la sensibilità europea del regista, con risultati alterni ma sempre riconoscibili.
Takashi Miike, enfant terrible del cinema giapponese, firmò quello che sarebbe diventato l’episodio più controverso dell’intera serie: “Imprint“. Talmente estremo nelle sue rappresentazioni di violenza, tortura e perversione da essere bandito dalla messa in onda televisiva americana (fu distribuito direttamente in DVD). L’episodio dimostrava quanto la promessa di libertà creativa della serie fosse reale, ma anche quanto il sistema americano, persino via cavo, avesse comunque dei limiti invalicabili!
Accanto a questi tre pilastri, la serie vantava contributi di altri maestri riconosciuti come Tobe Hooper (“Dance of the Dead“, “The Damned Thing“) e Stuart Gordon (“Dreams in the Witch-House“, “The Black Cat“). E ancora, Joe Dante (“Homecoming“, “The Screwfly Solution“), John Landis (“Deer Woman“, “Family“) e Don Coscarelli (“Incident On and Off a Mountain Road“).
Significative, però, furono anche alcune assenze. George A. Romero, padre dello zombie movie moderno, non partecipò mai al progetto, così come Wes Craven, creatore di “Nightmare” e “Scream“. David Cronenberg, maestro del body horror, declinò invece l’invito. Altri registi più giovani, ma già affermati, come James Wan o Eli Roth, non furono proprio coinvolti. Si evidenziava così una certa tendenza della serie a guardare più al passato glorioso del genere, che al suo presente o futuro…
Gli Episodi Più Rappresentativi – Tra Classicismo e Innovazione
Analizzando i 26 episodi prodotti nelle due stagioni, emerge un quadro variegato ma con alcune tendenze dominanti. La maggior parte degli episodi si inseriva in filoni classici dell’horror: storie di fantasmi, mostri, serial killer, possessioni demoniache e creature soprannaturali. Pochi osavano esplorare territori nuovi o utilizzare l’horror come veicolo per messaggi sociali o politici.
“Cigarette Burns” di John Carpenter rappresenta forse l’apice qualitativo della serie. È la storia di un cercatore di film rari incaricato di trovare “La Fin Absolue du Monde“, una pellicola leggendaria che avrebbe causato una strage durante la sua unica proiezione. Si tratta di una riflessione sofisticata sul potere delle immagini e sull’ossessione cinefila. Carpenter utilizza il formato breve con maestria, costruendo una tensione crescente che culmina in un finale tanto filosofico quanto disturbante. L’episodio dimostra come l’horror possa essere veicolo di riflessioni meta-linguistiche complesse, pur mantenendo la sua efficacia viscerale.
LEGGI ANCHE: Horror – Un genere di denuncia
“Jenifer” di Dario Argento, tratto da un fumetto di Bruce Jones, esplora l’ossessione erotica attraverso la storia di un poliziotto che salva una donna deforme ma sessualmente irresistibile, scoprendo troppo tardi la sua natura mostruosa e cannibale. L’episodio è tipicamente argentiano nella sua fusione di erotismo e orrore, ma soffre di un ritmo irregolare e di effetti speciali non sempre all’altezza. Rappresenta comunque un interessante tentativo di tradurre la sensibilità europea del regista in un contesto produttivo americano.
“Imprint” di Takashi Miike merita un discorso a parte. Ambientato in un bordello del Giappone feudale, l’episodio segue un americano alla ricerca della prostituta di cui si era innamorato, scoprendo una storia di abusi, deformità e vendetta di una brutalità inaudita. Troppo estremo persino per Showtime, che si rifiutò di trasmetterlo, l’episodio dimostra i limiti della presunta libertà creativa offerta dalla televisione americana, anche via cavo. Paradossalmente, questa censura ha contribuito alla sua fama di episodio “maledetto”, aumentandone il fascino presso gli appassionati del genere.
Tra gli altri episodi degni di nota ricordiamo “Incident On and Off a Mountain Road” di Don Coscarelli e “The Fair Haired Child” di William Malone. Il primo ribalta intelligentemente i tropi della “final girl” dell’horror slasher. il secondo è una fiaba gotica di rara efficacia. Ancora, “Sounds Like” di Brad Anderson, è un horror psicologico minimalista centrato sull’iperacusia di un impiegato d’ufficio.
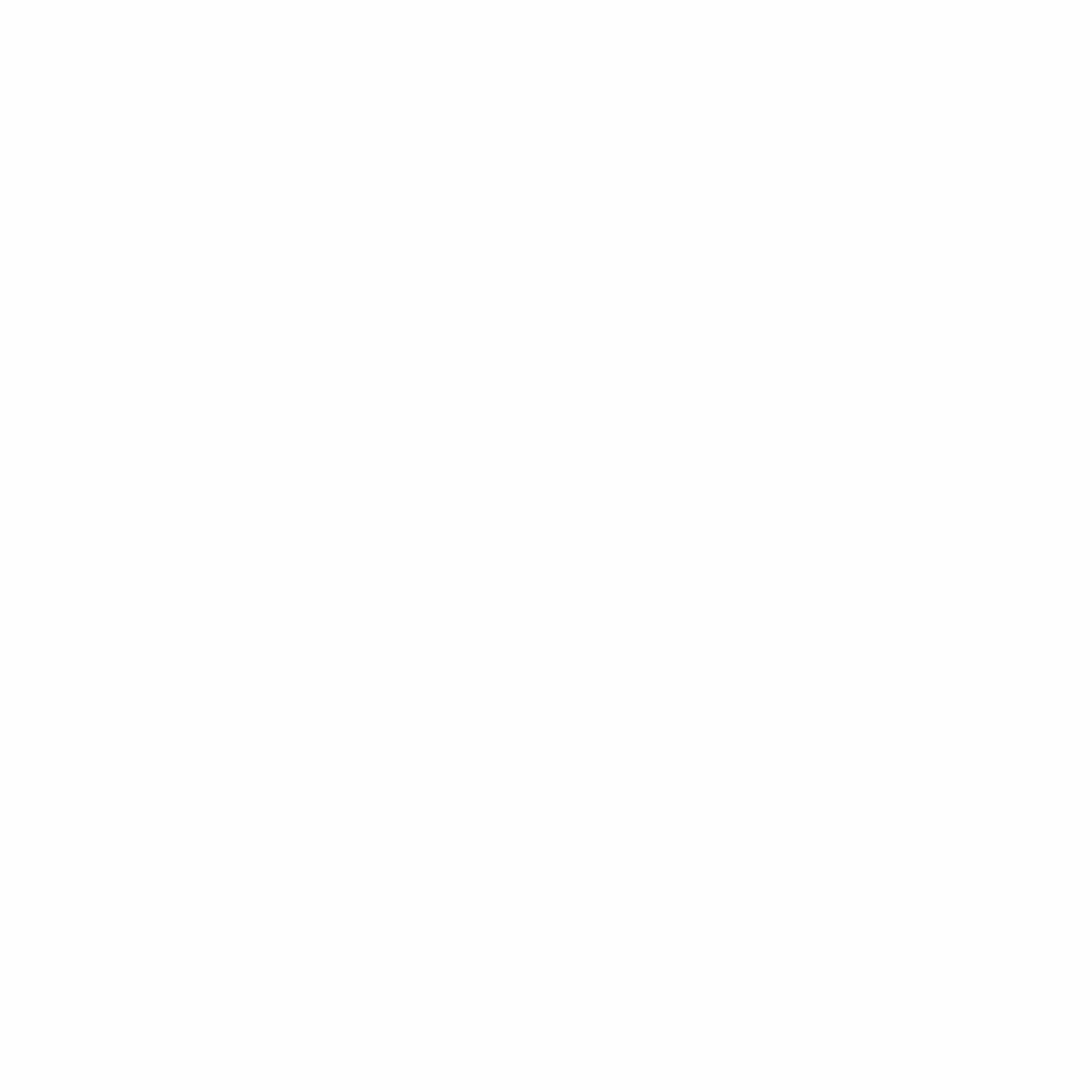
Homecoming – L’Eccezione Politica Firmata Joe Dante
In un panorama dominato da storie horror tradizionali, “Homecoming” di Joe Dante spicca come una clamorosa eccezione. Trasmesso il 2 dicembre 2005, nel pieno della guerra in Iraq, l’episodio rappresenta la più esplicita critica politica mai veicolata attraverso il formato della serie.
La trama è tanto semplice quanto potente. Durante un dibattito televisivo, un consulente politico repubblicano afferma che se potesse riportare in vita i soldati morti in Iraq per far loro dire che il loro sacrificio è valso la pena, lo farebbe! Il suo desiderio si avvera in modo imprevisto però. I soldati caduti tornano effettivamente dalla tomba, ma non per sostenere la guerra, bensì per votare contro l’amministrazione che li ha mandati a morire.
Dante, regista noto per il suo impegno politico progressista, utilizza il sottogenere zombie non per generare paura, ma come veicolo di satira politica feroce. I morti viventi di “Homecoming” non sono mostri assetati di carne umana, ma cittadini che reclamano il loro diritto democratico fondamentale. Il loro unico desiderio è votare, non divorare cervelli!
LEGGI ANCHE: Cabinet Of Curiosities – Differenze tra serial e antologia
L’episodio prende di mira senza mezzi termini l’amministrazione Bush. La retorica patriottica utilizzata per giustificare la guerra in Iraq e figure mediatiche dell’epoca come Ann Coulter (parodiata nel personaggio di Jane Cleaver). La critica si estende anche ai media compiacenti e all’uso cinico dei veterani come props politici. Temi che mantengono una sconfortante attualità anche nel panorama politico contemporaneo…
“Homecoming” rappresenta un raro esempio di horror apertamente politico nella televisione americana mainstream dell’epoca. Mentre la maggior parte degli episodi di Masters of Horror guardava al passato del genere, Dante guardava al presente e al futuro. Riuscì così a dimostrare come l’horror potesse essere veicolo di critica sociale diretta ed efficace. Non a caso, l’episodio ricevette il premio della critica televisiva come miglior film per la televisione del 2005.
La scelta di Showtime di trasmettere un contenuto così esplicitamente politico in prima serata, nel contesto di una serie horror, dimostra un coraggio editoriale che raramente si è visto replicato nelle produzioni mainstream successive, e che rende “Homecoming” un documento storico oltre che un’opera di intrattenimento.
Nostalgia Contro Innovazione – Masters of Horror È Una Serie Rivolta al Passato
Analizzando Masters of Horror nel suo complesso, emerge chiaramente, come abbiamo già sottolineato, come la serie fosse prevalentemente orientata verso il passato del genere piuttosto che verso il suo futuro. Questa tendenza si manifesta in diversi aspetti della produzione.
In primo luogo, la scelta stessa dei registi privilegiava figure che avevano raggiunto l’apice della loro carriera negli anni ’70 e ’80, con poche eccezioni come Lucky McKee o William Malone. L’assenza di voci più giovani e innovative come quelle che stavano emergendo nel cinema indipendente dell’epoca (si pensi a registi come James Wan, Eli Roth o Rob Zombie) conferiva alla serie un’aura nostalgica, quasi museale.
Anche a livello tematico e stilistico, la maggior parte degli episodi si inseriva in filoni classici dell’horror e pochi osavano esplorare territori nuovi o utilizzare l’horror come veicolo per messaggi sociali o politici.
Questa tendenza conservatrice si rifletteva anche nell’approccio visivo. Molti episodi adottavano un’estetica deliberatamente retrò, con illuminazione, montaggio e effetti speciali che richiamavano l’horror degli anni ’70 e ’80. Anche quando trattavano temi contemporanei, lo facevano spesso attraverso il filtro di convenzioni visive consolidate.
LEGGI ANCHE: William Friedkin un visionario “senza cravatta”
Il confronto con altre serie antologiche dell’epoca o successive è illuminante. “Fear Itself“, erede spirituale di Masters of Horror trasmesso da NBC nel 2008, soffriva di limitazioni ancora maggiori dovute alla televisione in chiaro. D’altra parte, serie più recenti come Black Mirror hanno dimostrato come il formato antologico possa essere utilizzato per esplorare temi contemporanei attraverso lenti di genere innovative.
Questa proiezione verso il passato non è necessariamente un difetto. In un’epoca in cui l’horror cinematografico mainstream stava attraversando una fase di remake, sequel e produzioni formulaiche, Masters of Horror offriva uno spazio per un approccio più autoriale e personale al genere. La serie celebrava una tradizione horror classica che rischiava di essere dimenticata nel panorama commerciale dell’epoca.
Tuttavia, con il senno di poi, appare evidente come la serie abbia mancato l’opportunità di essere un laboratorio di innovazione per il genere. In un momento in cui l’horror stava iniziando a evolversi verso forme più socialmente consapevoli e tecnicamente innovative (si pensi a film come “The Descent” o “Let the Right One In” usciti in quegli anni), Masters of Horror rimaneva in gran parte ancorata a formule consolidate.
L’Eredità di Masters of Horror nel Panorama Contemporaneo
A quasi vent’anni dalla sua prima messa in onda, quale eredità ha lasciato Masters of Horror nel panorama dell’horror televisivo contemporaneo?
La serie ha indubbiamente contribuito a legittimare l’horror come genere televisivo serio e autoriale, in un’epoca in cui era ancora considerato marginale o di serie B. Il suo formato antologico, che permetteva storie complete in un singolo episodio, ha anticipato il ritorno di popolarità delle antologie che si sarebbe verificato negli anni successivi con serie come “American Horror Story” (seppur con una struttura stagionale), “Channel Zero” o il revival di “The Twilight Zone“.
L’influenza di Masters of Horror è particolarmente evidente in diversi progetti. Ad esempio in “Creepshow” (2019), serie antologica Shudder che riprende esplicitamente l’idea di offrire a registi horror uno spazio creativo libero. Ma anche “Cabinet of Curiosities” di Guillermo del Toro, per Netflix, adotta un approccio curatoriale simile riunendo registi di genere sotto un’unica bandiera.
Tuttavia, l’eredità più significativa della serie risiede forse nel suo approccio alla libertà creativa. In un’epoca in cui le piattaforme di streaming hanno moltiplicato gli spazi per contenuti di nicchia, l’idea di dare carta bianca a creatori di genere appare meno rivoluzionaria di quanto non fosse nel 2005! Eppure, guardando al panorama attuale, ci si chiede se esista davvero uno spazio equivalente dove registi horror possano esprimersi con la stessa libertà…
LEGGI ANCHE: L’esorcista – dalle stelle alle stalle
Le piattaforme di streaming contemporanee, pur offrendo maggiori opportunità per contenuti di genere, tendono a imporre formati standardizzati e a privilegiare progetti con potenziale commerciale immediato. L’approccio curatoriale di Mick Garris, basato sul rispetto per l’autorialità e sulla passione condivisa per il genere, appare quasi anacronistico nel panorama industrializzato dell’intrattenimento contemporaneo.
In questo senso, Masters of Horror rappresenta un esperimento difficilmente replicabile nell’ecosistema mediatico attuale. Un progetto nato dalla passione più che dal calcolo commerciale, che ha riunito creatori di diverse generazioni e sensibilità sotto l’egida di un genere amato.
Guardando al presente, serie come “The Haunting of Hill House” di Mike Flanagan o “Lovecraft Country” di Misha Green dimostrano come l’horror televisivo contemporaneo abbia evoluto l’approccio autoriale in formati più estesi e complessi. Andando ad integrare tematiche sociali e politiche in modo più organico e sofisticato rispetto a quanto facesse Masters of Horror. Eppure, manca forse quella purezza di intenti, quella celebrazione del genere fine a se stessa che caratterizzava il progetto di Garris.
Episodi come “Homecoming” di Joe Dante appaiono oggi sorprendentemente profetici nella loro critica politica, anticipando l’uso dell’horror come veicolo di commento sociale. Una modalità che sarebbe diventata dominante nel genere con film come “Get Out” di Jordan Peele o “The Babadook” di Jennifer Kent. Eppure, questi esempi rimanevano l’eccezione piuttosto che la regola all’interno della serie.
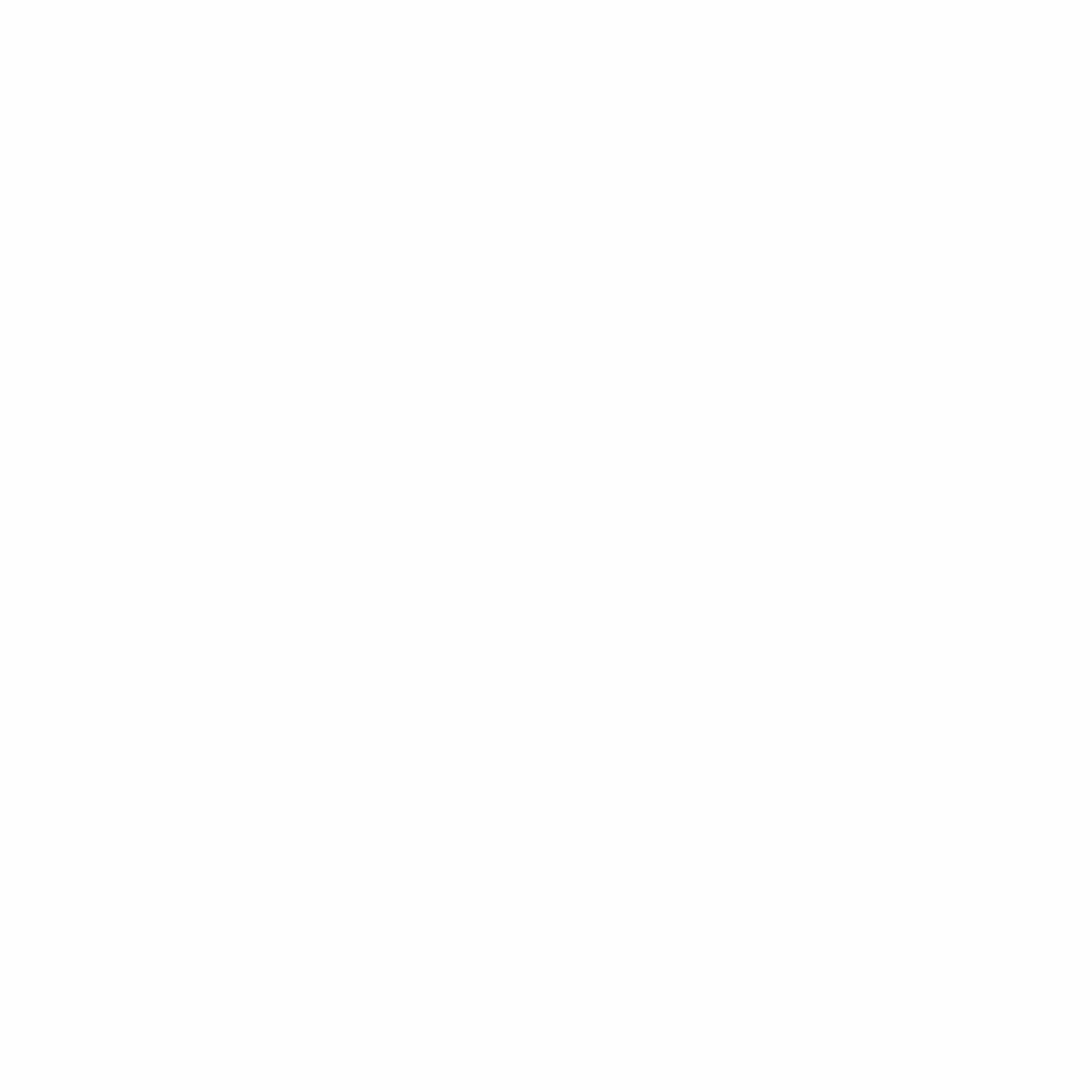
Masters of Horror: Un Esperimento Imperfetto ma Necessario
Masters of Horror rimane un esperimento televisivo affascinante proprio per le sue contraddizioni. Una serie che guardava prevalentemente al passato del genere, eppure occasionalmente ne anticipava il futuro. Un progetto che celebrava l’autorialità in un formato industriale. Un’antologia che oscillava tra il compiacimento nostalgico e l’innovazione radicale.
Il suo maggior pregio fu probabilmente quello di creare uno spazio creativo in un’epoca in cui l’horror d’autore faticava a trovare sbocchi commerciali. Per molti dei registi coinvolti, gli episodi di Masters of Horror rappresentarono rare opportunità di espressione in un periodo di carriera in cui Hollywood li aveva in gran parte dimenticati.
Il suo limite principale fu quello di non osare abbastanza. Di rimanere troppo ancorata a una visione tradizionale del genere, in un momento in cui questo stava iniziando a evolversi verso forme più complesse e socialmente consapevoli. Con poche eccezioni come “Homecoming“, la serie raramente utilizzò l’horror come lente per esplorare le ansie sociali contemporanee, preferendo rimanere nel territorio familiare di mostri, fantasmi e assassini.
Eppure, proprio questa tensione tra tradizione e innovazione, tra celebrazione nostalgica e occasionali lampi di audacia, rende Masters of Horror un documento prezioso dell’evoluzione del genere. La serie cattura un momento di transizione, in cui l’horror televisivo stava iniziando a emergere dall’ombra del cinema per trovare una propria identità.
In un’epoca in cui l’horror è diventato uno dei generi più vitali e innovativi del panorama culturale, capace di vincere Oscar e generare discussioni critiche sofisticate, Masters of Horror appare come un antenato imperfetto ma necessario. Un esperimento che, pur guardando prevalentemente al passato, ha contribuito a preparare il terreno per il futuro del genere.
La sua eredità più duratura non risiede tanto nei singoli episodi, quanto nell’idea che l’horror televisivo potesse essere un veicolo per visioni autoriali complesse e diverse. Un’idea che, pur realizzata in modo imperfetto, ha contribuito a elevare lo status culturale di un genere troppo spesso sottovalutato, aprendo la strada alle eccellenze dell’horror televisivo contemporaneo.


