Tra i titoli in concorso all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ne spicca uno sia per il genere che per il nome del suo regista. Il regista messicano Guillermo del Toro porta infatti a Venezia la sua ultima fatica adattando il libro principe della letteratura gotica: Frankenstein.
Quello che non voglio è che voi abbiate l’impressione di guardare un classico interpretato con reverenza, ma con l’urgenza di qualcosa che è vivo adesso.
Guillermo del Toro
Accolto da oltre venti minuti di applausi in Sala Grande, Frankenstein offre una rilettura moderna del mito del novello Prometeo, senza però venire meno alla fedeltà nei confronti dell’opera che del Toro non solo dimostra di conoscere, ma anche e soprattutto di rispettare.
Frankenstein ha una sola madre, ma molti padri che hanno proposto adattamenti sia sullo schermo che sulla carta. Del Toro si prende la responsabilità di rispondere alla domanda che tutti coloro che hanno letto il libro si sono posti, almeno una volta:
Chi è il vero mostro, la creatura o il suo creatore?
Frankenstein sposta l’attenzione dalla domanda fondamentalmente religiosa che permea l’opera letteraria, cioè se l’uomo possa o meno sostituirsi a Dio, a quella più umana: cosa succede se un padre abbandona il figlio a se stesso?
Il rapporto tra padri e figli è il filo conduttore di tutta la storia. Il giovane Victor Frankenstein (Oscar Isaac) ama la madre così quanto detesta il padre. È inevitabile che questo rancore mai davvero sopito si riversi su un altro figlio, creato non generato, ma non per questo meno bisognoso di cura e attenzioni.
Se ci fosse il premio padre inventato dell’anno andrebbe di diritto a Charles Dance che ancora una volta veste i panni del personaggio più odioso di un film.

Frankenstein è Un sogno gotico magistralmente realizzato
A livello di costumi e scenografie Frankenstein ammalia lo spettatore fin dalle prime scene, barocche nel loro sfarzo, eppure puntuali.
Il nero come colore che caratterizza gli uomini, ottusi nel loro sapere e nel modo in cui gestiscono il potere, quello sulla famiglia nel caso del Barone Frankenstein.
Il rosso che diviene il colore di lei, della madre così amata, la sola fonte di luce nella vita del giovane Victor, ma che è anche il colore del sangue.
Per giungere poi al dettaglio più importante di tutti. Il colore che si fa strada nella vita di Victor. I guanti rossi della madre che ricoprono le sue mani, quelle mani che il barone non osa più toccare, neanche per punizione, perché divengono delicati strumenti di lavoro.
Poi esplodono sullo schermo le costruzioni della Londra Vittoriana, grigia, cupa, bagnata e fredda.
Tutto diviene uno spettacolo per gli occhi. Tutto assolve al fine ultimo di una scenografia realizzata da mani esperte: portare lo spettatore dentro alla storia, perché tutto deve aiutare nella narrazione.
Le strade di Londra raccontano della vita che Victor conduce. La maestosità delle case della nobiltà e dell’alta borghesia narrano la storia di chi ce l’ha fatta, come William, adesso fidanzato, e lasciano Victor ai margini, ospite mai davvero voluto.
L’atmosfera che lo avvolge punta l’attenzione dello spettatore su quello che lentamente traspare dallo schermo. Victor è assorbito nella sua stessa grandezza, o meglio nell’idea che lui ha della sua grandezza. Senza rendersene conto, Victor si trasforma sotto gli occhi degli spettatori ormai rapiti dalla storia, in quello che ha sempre disprezzato: suo padre.
In contrasto la luce abbagliante dei ghiacci perenni dove l’ultimo confronto tra creatura e creatore si consuma.
Chi è il vero mostro?
Come si vive con un cuore infranto, e che cosa si fa quando il nostro cuore si rompe? Spesso gli atti di crudeltà nascono da cuori infranti.
Oscar Isaac
Frankenstein non lascia dubbi sull’argomento. Il mostro, quello vero, quello che non si rende conto delle sue azioni e non se ne cura, che insegue il sogno di poter sovvertire l’ordine naturale e l’equilibrio tra vita e morte per sostituirsi a Dio stesso, è Victor.
Un uomo che vuole alzarsi sopra ogni altro, che vuole donare al mondo la sconfitta della morte stessa, ma che non si rende conto che così facendo distruggerà tutto quello che ha, fino a perdere anche l’ultima persona che riusciva a volergli bene.
Lo stesso uomo che non si rende conto che la morte non è mai stata vista come una punizione.
Può qualcuno che non è mai stato amato insegnare ad amare? Questa è la domanda che lo spettatore è portato a porsi, più e più volte nel corso del film.
Victor ha amato sua madre, ma quell’amore era possessivo, territoriale e geloso. Un amore malato che lascia dietro un vuoto troppo grande da colmare.
Nelle precedenti trasposizioni sullo schermo di quest’opera l’attenzione dei registi, nella creazione del mostro si è sempre posata sul grottesco e sul macabro. Viti e bulloni che spuntano dal collo, punti di sutura che sfregiano e deturpano. Tutto è troppo grande, troppo sproporzionato.
Questo Frankenstein (Jacob Elordi) è bello invece, di una bellezza struggente, dove le cicatrici sono solo un modo per raccontare una storia, non per sminuire il personaggio.
Nato dall’unione di cadaveri, la creatura porta con sé la memoria di coloro che lo hanno formato. Alto, grande e forte, troppo forte, è un bambino che apre gli occhi sul mondo per la prima volta. Non ricorda nulla di quello che è stato prima, ma prova freddo, paura, fame e soprattutto prova emozioni che vengono ignorate da Victor.
Victor lo rifiuta, improvvisamente spaventato da quello che ha fatto, ma nel suo egocentrismo, offeso dal fatto che la creatura non sembra essere intelligente. Come può un uomo che ha sempre pensato di essere superiore a tutti gli altri, arrivare a creare un abominio che ha la colpa di essere stupido?
E mentre il rancore di Victor cresce, la creatura fa quello che ogni bambino farebbe nella sua situazione, dice la sua prima parola: Victor.
Frankenstein vuole mostrare che la violenza non è intrinseca nell’animo umano, e la mancanza di essa non dipende dal concetto di anima.
Si può essere crudeli e spietati anche se si nasce nel modo più canonico, e si può diventare gentili se ci viene insegnato ad esserlo.
LEGGI ANCHE: Frankenstein di Mary Shelley: quando il mostro lo crea la società
La creatura desidera solo essere accettata e viene invece scacciata. Vuole una famiglia, ma la sola famiglia che ha, lo rifiuta. Desidera amare, ma è solo. Agogna il riposo eterno, ma non può morire.
Allora quello che resta da fare è provare rabbia, dolore, odio anche, nei confronti di chi lo ha creato e poi abbandonato.
Fino alla fine inevitabile. L’ultimo incontro, l’ultimo tentativo di distruggere quella creatura che non ha un posto in questo mondo.
Poi la comprensione. Il nome di Victor, detto tre volte, ripetuto in maniera ossessiva e irritante è l’equivalente di un bambino che dice la sua prima parola. La creatura non può dire mamma e dunque pronuncia il nome del padre.
Il mio nome me lo ha dato mio padre, non ha mai avuto importanza. Dillo ancora, come all’inizio, quando invece era la cosa più importante del mondo. Victor Frankenstein
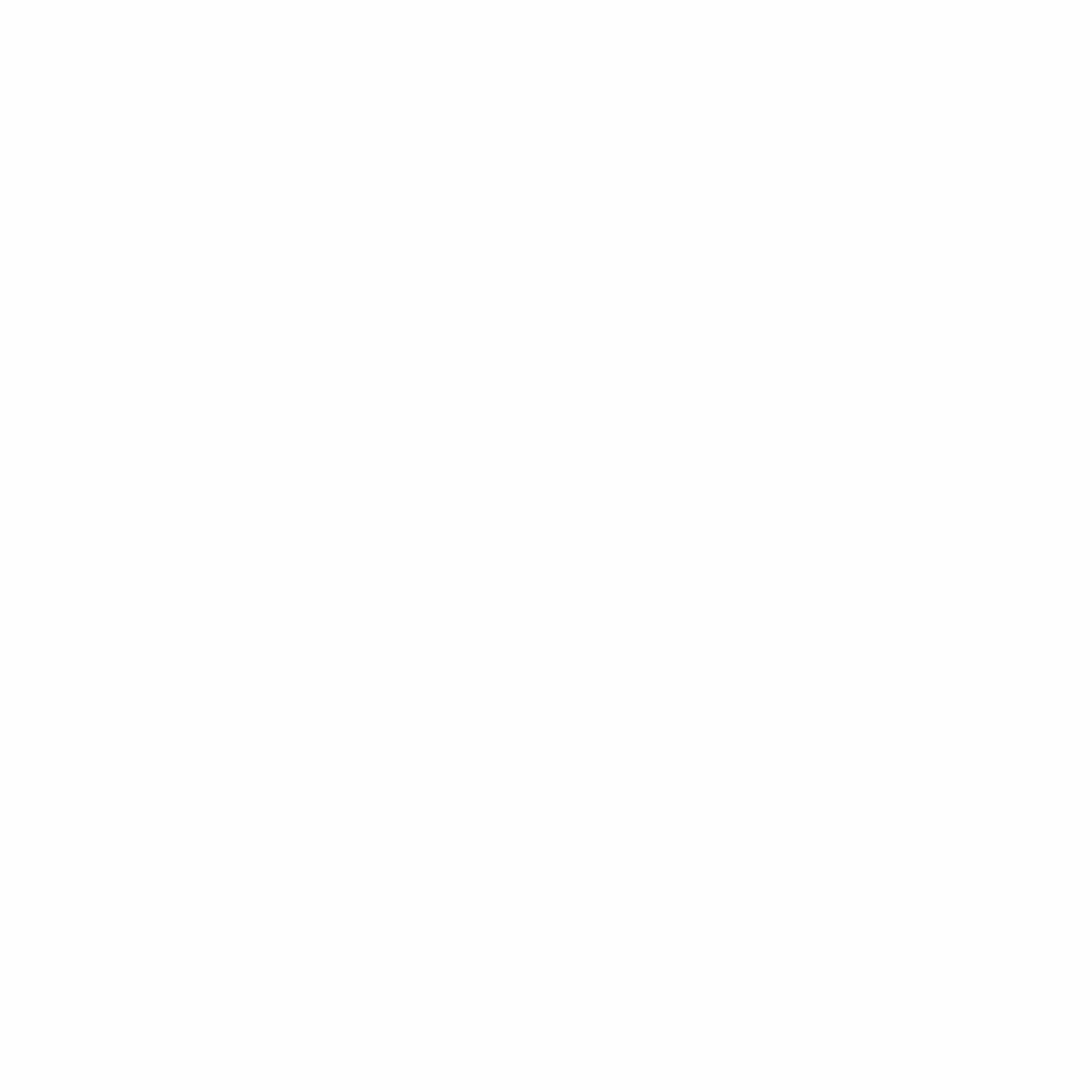
Conclusioni su Frankenstein
Frankenstein è una storia di perdono e accettazione di se stessi e degli altri.
Un film da vedere e da godersi. Pienamente sufficiente con delle vette di perfezione.
Se la volontà del regista verrà rispettata, il film sarà visibile nelle sale, altrimenti non resta che aspettare l’uscita su Netflix…


